Adattamento nutrizionale e difficoltà a dimagrire
Con l’espressione di adattamento nutrizionale (nutritional adaptation) si intende la risposta dell’individuo a deficit o eccessi di energia e di nutrienti che si protraggono nel tempo. L’adattamento nutrizionale ha il fine di preservare l’integrità anatomica e funzionale dell’organismo e coinvolge allo stesso tempo meccanismi biochimici, ormonali e comportamentali.
Sono convinta che per poter comprendere un argomento non si possa prescindere dalla conoscenza dei termini e della loro etimologia.
Etimologia del termine adattamento
Il termine adattamento deriva dal latino adaptare, formato da ad + aptare = adattare, accomodare, assestare. Molte sono le valenze del termine adattamento: in biologia, in fisiologia, in psicologia, in diritto, in letteratura, in cinematografia, in musica.
Nella sua accezione più utilizzata, comunque, è un processo attraverso cui un individuo si adegua all’ambiente (fisico e sociale), modificando i propri schemi di comportamento (adattamento passivo) oppure operando sull’ambiente stesso, per trasformarlo, in funzione delle proprie necessità (adattamento attivo).
Adattamento, dall’etimologia alla fisiologia
È necessario adattarsi, in primo e fondamentale luogo, all’ambiente naturale. La nostra è una storia antica. Nel nostro patrimonio genetico sono ancora racchiuse le informazioni che rendono possibile sopravvivere alle carestie. Il patrimonio genetico è lo stesso dei nostri avi ma l’ambiente in cui viviamo è profondamente cambiato. Essere geneticamente adatti a fronteggiare le carestie mentre viviamo in un mondo in cui il cibo abbonda e la sedentarietà impera è un bel guaio.
Secondo dati dell’OMS nel 2008 oltre 500 milioni di adulti erano classificabili come obesi con un Indice di Massa Corporea (o Body Mass Index) superiore a 30. I geni selezionati nei periodi di carestia (genotipo risparmioso) a fronte dell’eccessivo introito energetico e della sedentarietà che caratterizzano la vita moderna sono alla base di questo trend. E così di fronte alla pandemia di obesità (gli esperti parlano di globesity) e di malattie correlate (la sindrome plurimetabolica le racchiude tutte) c’è una ricerca continua di soluzioni.
Tra le soluzioni di primo livello (ancor prima della terapia farmacologica o della chirurgia dell’obesità) ci sono le diete. La scienza della nutrizione è una branca della medicina relativamente recente. Poggia le sue basi sulla fisiologia e sulla biochimica. Eppure, negli ultimi decenni all’approccio scientifico si è andato sovrapponendo un mercato delle diete di dubbia serietà.
La dieta di turno, quella resa famosa dalla testimonianza di qualche influencer, viene proposta ogni volta come la migliore in assoluto e, cosa ancor più grave, come la migliore in assoluto per tutti (one-size-fits-all). Molte di queste diete hanno la caratteristica di essere fortemente ipocaloriche per difetto ora di carboidrati, ora di grassi e ora di entrambi questi macronutrienti.
Le diete fortemente ipocaloriche ci ricordano ogni volta che siamo adatti a sopravvivere alle carestie. Una significativa riduzione dell’introito calorico giornaliero porta il nostro organismo a consumare meno energia.
Dunque, diete inappropriate + sedentarietà + adattamento nutrizionale (legato al genotipo risparmioso) sono il motivo per cui molte persone incontrano difficoltà nel dimagrire e tendono, invece, ad aumentare di peso con estrema facilità.
L’adattamento nutrizionale alle diete inadatte
Sono molte le persone che lamentano difficoltà a dimagrire. Nella gran parte dei casi, complice lo stile di vita odierno, si preferisce ridurre ai minimi termini l’apporto calorico mentre si passa la gran parte della giornata in piena sedentarietà. Viviamo nella società delle prestazioni, la massima performance è diventata un imperativo sociale tanto che per essa abbiamo sacrificato il nostro benessere. C’è ancora qualcuno che rispetta la pausa pranzo, o che rallenta un po’ i propri ritmi dopo aver mangiato, o che si predispone ad un buon riposo notturno attraverso la pratica di attività rilassanti come una piacevole lettura o l’ascolto della musica, la contemplazione di un’opera d’arte, la pratica della meditazione?
Conosco persone che vengono trattenute in ufficio perché il loro capo ha previsto una riunione all’ultimo momento, persone che rispondono al telefono dopo le nove di sera, persone che con lo smart working rimangono incollate al computer per dieci ore al giorno. Si tratta di situazioni alienanti che, per la frequenza con la quale si verificano, abbiamo cominciato a considerare normali.
Noi le consideriamo normali ma il nostro Sistema PNEI (psico-neuro-endocrino-immunologico) no. Sorprende che lo stile di vita che abbiamo scelto sia così antitetico rispetto a cosa dicono le nostre conoscenze scientifiche. Degli effetti dello stress cronico sulla nostra salute sappiamo già da tempo.
Adattamento e stress cronico
Tutto cominciò con un giovane e sconosciuto assistente universitario il cui campo di ricerca era l’endocrinologia. Il suo nome era Hans Selye.
Selye, volendo testare gli effetti di un estratto ovarico su una popolazione di topolini, li sottoponeva quotidianamente ad un’iniezione ma nel farlo doveva essere un po’ maldestro. Come racconta Robert M. Sapolsky nel suo bellissimo libro “Perché alle zebre non viene l’ulcera?”, Selye “provava a iniettare, ma non ci riusciva, lasciava cadere gli animali, passava metà della giornata a rincorrerli per la stanza o viceversa, battendo con un bastone per farli uscire da dietro il lavandino, e così via”.
Sta di fatto che dopo mesi di questo trattamento Selye scoprì che i suoi topini, così martoriati, avevano sviluppato ulcere peptiche, avevano un’ipertrofia delle ghiandole surrenali e un’atrofia dei tessuti immunitari. Inizialmente Selye attribuì questi effetti all’azione dell’estratto ovarico. Ma quando da bravo scienziato instituì un gruppo di controllo, cioè a dire una seconda popolazione di topini a cui iniettava quotidianamente una soluzione fisiologica al posto dell’estratto ovarico, poté verificare che anche questi andavano incontro allo stesso destino.
A questo punto Selye concluse che a causare l’ulcera, l’ingrandimento delle ghiandole surrenali e l’immunodepressione dovevano essere le sue iniezioni e non la sostanza testata.
In generale quando un organismo viene sottoposto ad un fattore di stress si susseguono tre diversi stadi. Dopo una prima fase di allarme, l’organismo sviluppa una resistenza che, se inefficace e prolungata, degenera in una fase di esaurimento.
Durante lo stress aumenta la secrezione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali, le stesse che Selye trovava ipertrofiche nei suoi topini. Il nostro asse dello stress consta di tre ghiandole in grado di influenzare l’una l’attività dell’altra. Sono ipotalamo, ipofisi e surrene. Quando nel torrente ematico c’è troppo cortisolo, viene inibita la produzione di ACTH (ormone adrenocorticotropo) da parte dell’ipofisi. Essendo l’ACTH l’ormone che stimola il surrene a produrre cortisolo e altri glucocorticoidi, la caduta dell’ACTH si tradurrà in una ridotta produzione di questi ormoni. È quello che in endocrinologia viene definito sistema a feedback negativo.
Nello stress cronico però tanto l’ACTH che il cortisolo si trovano ad un valore di riferimento inadeguato.
Nello stadio di allarme l’organismo è allertato dagli stimoli esterni che vengono percepiti come potenziali pericoli. Sono state individuate tre possibili reazioni al pericolo: la fuga, la lotta e l’immobilità. Il fisiologo Walter Cannon, antecedente a Selye, formulò la celebre frase “fight-or-flight” ovvero lotta o fuggi per descrivere la risposta allo stress.
Come avviene in natura quando un coniglio scappa dal suo predatore, con la fuga l’organismo cerca di sfuggire dal pericolo. I predatori invece si dispongono alla lotta: è il caso del leone che insegue la gazzella! Alla base dell’immobilità c’è invece il principio che non fare nulla è meglio che fare qualcosa di sbagliato. Restando immobile l’organismo spera di non essere notato.
Durante la fase di resistenza si va incontro ad una maggiore secrezione di glucocorticoidi il cui scopo in natura è quello di sopprimere la sensazione di disturbo. La logica che sta dietro questo tipo di reazione è facilmente comprensibile: la preda che scappa dal leone non avvertirà il dolore legato all’infiammazione, sarà invece concentrata sulla fuga e avrà in questo modo più probabilità di salvarsi!
I problemi sopraggiungono quando la fase di resistenza si prolunga nel tempo come avviene per la gran parte di noi. Al giorno d’oggi non ci capita spesso di dover scappare da un predatore o da un pericolo imminente, ma abbiamo di certo a che fare con fattori di stress cronico! Qualche esempio? Il traffico la mattina per andare al lavoro, la fila all’ufficio postale, le bollette da pagare, la pagella dei figli, l’ago della bilancia che sale, la dieta affamante che scegliamo di fare ogni volta che ci sembra di lievitare…
È così che lo stress può portare a squilibri che si cronicizzano come l’iperinsulinismo, l’iperlipidemia, l’ipertensione, l’osteoporosi, l’infiammazione, l’accumulo di grasso viscerale solo per citarne alcuni.
Ma può andare anche peggio di così! Alla fase di resistenza può seguire la fase di esaurimento o burn out. A questo punto ci si sente perennemente affaticati, le nostre capacità di ragionamento sono compromesse, i pensieri sono confusi e disconnessi, si vive in una condizione di apatia come se nulla intorno a noi possa interessarci e si finisce con lo sviluppare malattie su base allergica o autoimmune (malattie Th2 mediate).
La dieta inadatta, perché eccessivamente ipocalorica e povera di valore nutrizionale, rappresenta un grande stress per l’organismo. È probabile che all’inizio si perda peso. Quello che è certo, però, è che l’effetto dimagrante non durerà a lungo e che una volta abbandonata la dieta si tenderà a recuperare tutto il peso perso e anche di più.
The Biggest Loser
Qualcuno di voi ricorderà la trasmissione americana The Biggest Loser. Le persone reclutate per prendere parte a questo reality erano affette da obesità grave (BMI superiore a 40). L’obiettivo del programma era quello di perdere più peso possibile grazie ad un articolato percorso fatto di dieta e attività fisica. Colui o colei che avesse perso più chili sarebbe stato il vincitore. Kevin D. Hall e colleghi del National Institutes of Health (NIH), hanno studiato peso, composizione corporea (massa magra e massa grassa) e metabolismo basale di 14 partecipanti al reality nei 6 anni a seguire la sua conclusione. La scoperta dei ricercatori è stata sorprendente. Anche se con il tempo i soggetti esaminati avevano recuperato un po’ del peso perso, il loro metabolismo basale rimaneva sensibilmente più basso rispetto a quello rilevato al tempo zero quando ancora questi erano in condizioni di obesità grave. La differenza tra metabolismo basale al peso di partenza e quello rilevato dopo sei anni dal raggiungimento del peso obiettivo era in media pari a 600 kcal.
È un esempio di adattamento nutrizionale che agisce in cronico e il cui scopo è quello di impedire un ulteriore calo ponderale.
Cosa dicono biochimica e fisiologia: il fabbisogno calorico giornaliero
Se vogliamo dimagrire l’unica cosa da fare è indurre un deficit energetico. Detto in altri termini bisogna mangiare meno di quello che si consuma, ma poiché il modo in cui ci esprimiamo è importante a me piace dire piuttosto che bisogna consumare più di quanto si mangia. In questo modo pongo l’accento sul dispendio energetico (leggasi movimento e attività fisica) e non sul deficit calorico (leggasi diete affamanti).
Ma allora la domanda è: come è possibile aumentare il nostro dispendio energetico totale giornaliero in modo che mangiando già solo un po’ meno l’ago della bilancia possa cominciare a scendere?
Il trasferimento di energia dall’organismo all’ambiente viene definito spesa energetica mentre il processo inverso viene detto introito energetico. La spesa energetica totale giornaliera consiste di quattro componenti:
- Il tasso metabolico durante il sonno (ebbene sì, consumiamo energia anche mentre dormiamo);
- Il costo energetico legato alla veglia;
- l’effetto termico degli alimenti o spesa energetica dieto-indotta (mangiando consumiamo energia);
- ed infine il costo energetico dell’attività fisica (è proprio il caso di dire sit less, get active).
Il tasso metabolico durante il sonno più il costo energetico legato alla veglia rappresentano assieme la spesa energetica per il mantenimento o tasso metabolico basale o metabolismo basale (è il parametro che è diminuito nei Big Loser).
Il metabolismo basale (BMR, Basal Metabolic Rate) rappresenta per definizione il minimo dispendio energetico misurabile mentre il soggetto è in stato di veglia. Lo si può rilevare attraverso la calorimetria indiretta con il soggetto disteso su un lettino a breve distanza dal risveglio e quindi in condizioni di completo riposo fisico e psico-sensoriale, in stato termo-neutrale (non deve avere né caldo né freddo), a 12-14 ore dopo l’assunzione dell’ultimo pasto. Può aumentare per effetto dell’attività fisica, dell’esposizione al freddo, del consumo di una dieta adeguata in termini qualitativi e quantitativi.
L’effetto termico legato agli alimenti viene detto anche termogenesi dieto-indotta (DIT, Diet Induced Thermogenesis). Viene definito come l’aumento della spesa energetica basale in risposta all’assunzione di un pasto. In un individuo medio che abbia un’alimentazione normale la DIT corrisponde al 10% del dispendio energetico totale giornaliero. La teoria più recente sostiene che la DIT è formata da due componenti: una DIT obbligatoria e l’altra facoltativa. La prima è da mettere in relazione con la spesa energetica che l’organismo compie per digerire, assorbire, trasportare e assimilare i nutrienti ingeriti. La DIT facoltativa (30-40% della DIT totale) sarebbe invece dovuta alla stimolazione del Sistema Nervoso Simpatico a seguito dell’assunzione dei carboidrati.
La spesa energetica necessaria per compiere qualunque tipo di attività fisica è la WIT (Work Induced Thermogenesis) Tipo, durata ed intensità del lavoro eseguito ne definiscono l’entità. In un individuo sedentario la WIT rappresenta il 20-30% del dispendio energetico totale giornaliero. Nello sportivo questa voce raggiunge il 50% ed oltre.
Se dunque l’obiettivo è quello di perdere peso e l’attività fisica rimane moderata la strategia giusta consiste nell’impostare un piano alimentare che apporti tante calorie quant’è il nostro metabolismo basale. Nell’individuo sedentario il metabolismo basale rende conto del 50-60% del dispendio energetico totale giornaliero. Il restante 50-40% potrà essere coperto andando a pescare energie dal grasso di deposito ed è così che si dimagrisce. Quando si segue un simile approccio la perdita di peso varia da mezzo chilo ad un chilo a settimana. In ogni caso dimagrire solo con la dieta oppure dimagrire con dieta e attività fisica non è la stessa cosa…
Muovetevi, mangiate e siate felici!
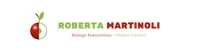

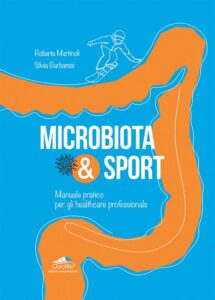
Lascia un commento